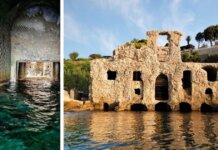Leggere il passato attraverso le opere d’arte
Il 27 settembre scorso è stato inaugurato nella Certosa di San Lorenzo a Padula un nuovo spazio espositivo, frutto del riallestimento degli antichi appartamenti del Priore, arricchiti, per l’occasione, di opere scultoree e pittoriche che decoravano gli ambienti del monastero nei secoli passati. Ma prima di addentrarci tra le sale degli appartamenti è necessario fare un breve excursus sulla figura del Priore della Certosa. Il Priore, guida generale dell’ordine certosino, era una figura bivalente: ministro spirituale da una parte, amministratore e politico dall’altra. Era lui che si occupava della cura dei confratelli, della supervisione delle attività del monastero, di gestire i rapporti con il mondo di fuori, con gli altri ordini monastici oppure con feudi e feudatari afferenti all’ordine. E i suoi alloggi si trovavano, indicativamente, in un punto strategico della Certosa: all’altezza del primo chiostro, subito dopo l’ingresso, tra la foresteria e il chiostro grande; ovvero a metà tra la Casa Piccola (gli spazi aperti a visitatori ed esterni) e la Casa Grande (quelli claustrali ad uso esclusivo dei monaci).

I suoi appartamenti, che oggi troviamo notevolmente ridimensionati per ampiezza, sono stati appunto oggetto di un riallestimento, che mette in mostra una serie di manufatti, selezionati tra quelli già appartenenti alla Certosa e dispersi a seguito delle spoliazioni napoleoniche del 1807 e delle leggi eversive del Regno d’Italia che nel 1866 soppressero gli ordini monastici, confiscandone le proprietà. A seguito di quei provvedimenti, molti dei beni custoditi nel monastero subirono – come quelli di numerosi altri siti religiosi – oltre che dispersioni, anche un destino d’incuria e abbandono pressoché totali. Infatti, le opere esposte nel Quarto del Priore sono solo una piccolissima parte di quelle che originariamente ornavano gli immensi spazi della Certosa e molte di loro (in particolare le sculture lignee e le tele più antiche) si portano ancora addosso le evidenti cicatrici di un triste passato di abusi e soprusi.

I pezzi oggi in mostra furono raccolti a partire dagli anni Ottanta del ‘900 e seguono l’andamento cronologico delle varie fasi costruttive del complesso, quindi vanno dal Trecento al Settecento. La ricerca propedeutica al riallestimento ha portato alla luce alcuni pezzi di grande fattura e bellezza, come i due bellissimi busti raffiguranti l’Annunciazione, scolpiti in adamantino marmo di Carrara. La mano che li fece nascere, nella seconda metà del XVII secolo, è quella di Domenico Guidi, scultore protagonista della grande stagione del barocco romano – insieme a Bernini e ad Algardi – tant’è che l’arcangelo annunciante di Padula è perfettamente sovrapponibile allo stesso soggetto scolpito da Guidi nella chiesa di Santa Maria della Vittoria a Roma, nella cappella di San Giuseppe, in pendant alla più nota Santa Teresa di Gian Lorenzo. Anche una tavola ad olio, dipinta nella metà del Cinquecento da Agostino Tesauro, pittore regnicolo attivo nel Regno di Napoli, merita la visita alle stanze del Priore. Si tratta di una Madonna delle Grazie, dipinta su fondo oro, nello stile un po’ arcaico tipico del pittore, con un volto di rara grazia e bellezza.
Ma la perla fra le perle del nuovo allestimento è una scultura in bronzo, che normalmente era collocata sull’altare della sagrestia della chiesa di San Lorenzo (sempre in Certosa), ma che per l’occasione è stata spostata nel Quarto del Priore. Si tratta di un tabernacolo ottagonale, alto circa due metri e mezzo, scolpito in tutte le sue parti, che culmina in un cupolino i cui spicchi sono divisi da piccole modanature. Già ad un primo sguardo si nota la somiglianza con un’altra cupola, ben più famosa e più grande, quella di Brunelleschi, ma, quando si osserva il resto della struttura e si vedono gli occhielli forati che decorano la base del tabernacolo, il riferimento diventa certezza. Dunque, citazioni fiorentine in un’opera realizzata nel profondo Regno di Napoli. Come è stato possibile? Partiamo dall’autore: Giacomo del Duca, classe 1520, scultore e architetto nato a Cefalù, molto attivo a Roma tra gli anni ‘60 e gli anni ‘80. E attivo non in un contesto qualsiasi, ma nella bottega di Mastro Michelangelo, che affiancò durante gli ultimi anni di vita, nei lavori per Porta Pia e per Santa Maria degli Angeli. In quest’ultima chiesa in particolare, Del Duca collaborò con il maestro toscano proprio alla realizzazione di un ciborio, di cui purtroppo oggi si sono perdute le tracce.

La commissione del tabernacolo di Padula, avvenuta nel 1572, per volontà dell’allora Priore della certosa, padre Filippo Ghetti, si giovò dell’efficiente rete di contatti locali e internazionali che i certosini avevano sempre intessuto e che consentì loro, in questa e molte altre occasioni, di potersi avvalere di manodopera specializzata, richiamata da località geograficamente distanti. Nei documenti relativi alla commissione del tabernacolo, infatti, risulta l’avallo anche di padre Basilio di Urbino, già Priore della certosa di Roma e, dal 1570, anche di quella di Santa Maria degli Angeli, proprio dove qualche anno prima, Michelangelo e Giacomo del Duca avevano lavorato al tabernacolo. A questo punto fare uno più uno risulta facile. Anche se non sono stati reperiti documenti ufficiali, è verosimile credere che possa essere stato Padre Basilio a fare da tramite tra Del Duca e i certosini di Padula. Otto episodi della vita di Cristo sono scolpiti in forma di rilievi, sulla fascia centrale del tabernacolo: in essi lo scultore trasfuse tutte le esperienze e lo stile michelangioleschi e i conseguenti riferimenti toscani. Infatti alcune di queste scene rivelano citazioni dai disegni di bottega di Michelangelo, in possesso dell’autore, che li aveva in parte ereditati alla morte del maestro, nel 1564. Il risultato è quello di un’opera di grande perizia e bellezza, con alcune pose anatomiche e particolari di composizione tipici del maestro fiorentino. Il tabernacolo, che grazie alla nuova collocazione è possibile ammirare in ogni particolare, è solo una delle tante testimonianze artistiche di ciò che la Certosa di Padula fu nei secoli passati: centro innovatore e propulsore di arte e cultura per tutto il sud Italia e, ancora oggi, nonostante l’incuria e la perdita di memoria, se si aprono bene gli occhi e il cuore, camminando lungo le mura scorticate e polverose dei suoi sconfinati corridoi, è possibile percepire chiaramente tutta la magnificenza del tempo che fu.